La coscienza del corpo
L’evoluzione della danza contemporanea dagli anni 80 all’equivoco dei finanziamenti per l’uso delle nuove tecnologie.

Come annunciato, riprendiamo oggi il discorso con Silvana Barbarini, danzatrice-coreografa ed organizzatrice culturale. La scorsa settimana ci eravamo lasciati con l’idea di parlare un po’ di quello che è stato il panorama della danza contemporanea italiana negli anni ‘80. E di come esso si sia modificato con lo scorrere degli anni e soprattutto con questo nuovo millennio.
Fino agli anni ottanta, infatti, l’Italia è stato un paese molto vitale culturalmente e anche se magari qualcuno non sarà d’accordo con l’idea di un progressivo degrado di questo paesaggio, ti chiedo di raccontami della tua formazione e del clima che c’era in quel periodo e poi negli ultimi anni del novecento. Insomma di come hai visto cambiare le cose fino ad oggi… E se anche tu, come me, pensi che sia avvenuto questo degrado culturale, se pensi che la responsabilità di ciò sia solo della classe politica…
C’era qualcosa di organico e di semplice. Un entusiasmo gigante. C’era anche un darsi una mano. Abbiamo sempre trovato il modo di realizzare i nostri progetti.
Una volta era il Lavatoio di Bianca Menna, una volta lo Ials di notte, una volta il Cid nelle ore buche, il mese al Malafronte che spettava a tutte le compagnie nell’elenco o il Vascello d’estate in cambio di qualche collaborazione. Quando non c’era un posto, allora andava bene anche lavorare per la strada. Dietro Castel S. Angelo c’era un viale con l’asfalto liscio, senza le macchine. Poi si prendeva il treno e si andava a vedere Bejart a Milano, Pina Bausch a Venezia, Nikolais a Firenze. Si mangiava un panino e si tornava la notte per non pagare l’albergo. Nel 1981 a Milano ho visto anche Douglas Dunn. E sono andata nei camerini a parlare con i danzatori e a chiedere dove avrei potuto abitare se volevo passare un anno a New York. E alla fine ho preso il posto di Susan Blankensop in un loft low cost di Chambers Street. Si, perché all’inizio degli anni ’80 si partiva per gli Stati Uniti, con in mano il libro di Leonetta Bentivoglio, e si approdava all’isola di Manhattan, dove gli studi di tutti gli artisti che avevano fatto la storia del ‘900 erano lì a portata di mano, a distanza di qualche strada. Così la mattina andavi da Nikolais, il pomeriggio da Cunningham, ogni tanto mettevi il naso altrove e la sera andavi a teatro. Il weekend facevi i compiti e il lunedi mattina ti presentavi davanti a Murray Louis con la tua composizione. Ogni settimana un tema diverso e anche durante il training tecnico (sempre uguale nella successione degli esercizi) spostavi la coscienza su quel tema: il tempo, lo spazio lontano, lo spazio vicino, le articolazioni… astrarre dalla realtà in termini di tempo, spazio, forma, energia..
Sono tornata dagli Stati Uniti con una grande voglia di lavorare e per vent’anni mi sono lanciata in avventure produttive, da sola e con altri.
A Roma negli anni ’80 danza contemporanea e teatro sperimentale si scambiavano idee e interpreti. La Zattera di Babele di Carlo Quartucci è stata un vero luogo d’incontro. Per esempio è lì che ho conosciuto Luigi Cinque e Massimo Cohen con cui dopo ho collaborato moltissimo. Il Censimento del Beat ’72 è servito a contarsi, senza la patina triste delle piattaforme o quella stucchevole del marketing.
Era nella logica delle cose che le istituzioni sostenessero gli artisti. Le risorse sono sempre state molto scarse, ma le opportunità erano più chiare. Sapevi dove andare e cosa fare.
I Festival dedicati alla sperimentazione erano pochi, ma c’erano. Nessuno chiedeva di dimostrare dei numeri, però di fatto ci andava tantissima gente. Penso a Polverigi, Sant’Arcangelo, Castiglioncello, Comacchio, Rovereto, Paola Leoni in Sardegna, e le varie rassegne di Nuovi Movimenti a Napoli, Catania, SettimoTorinese… ho visto recentemente un servizio fatto da Nico Garrone per Rai Tre sull’edizione 1987 del Festival di Polverigi. Entusiasmante! ti veniva voglia di essere lì.
A Roma, se volevi presentare un nuovo lavoro, ti mettevi d’accordo con un teatro. Si andava a incasso 70/30. Mettevi 100 locandine nel quartiere, portavi il comunicato stampa a tutti i giornali e il teatro si riempiva. I primi due giorni invitavi la stampa e gli amici. Il terzo giorno uscivano recensioni di mezza pagina su Repubblica, Corriere della Sera, il Messaggero, il Tempo, l’Avanti, l’Unità, il Manifesto… e arrivava il pubblico pagante. Avevi una bellissima rassegna stampa per promuovere il lavoro e quando si creava il passaparola giusto venivano a vederti organizzatori, registi, artisti visivi. Questo succedeva un po’ in tutte le città. Nascevano proposte di lavoro.
Si mettevano in moto altri progetti. E nel corso dei progetti nascevano nuove collaborazioni. A Parma è venuto a vederci Enrico Maghenzani e ci ha chiamati per collaborare alla creazione di Genesi di Franco Battiato. In quell’occasione abbiamo imparato a girare, siamo diventati dervisci. E’ stato un bell’incontro con i valori della cultura musulmana. Queste esperienze lasciavano un segno.
Spesso si è creata l’occasione di lavorare in altri paesi, anche se non esistevano ancora i progetti europei. Col Centro Sperimentale del Teatro siamo stati a Istanbul per una creazione, con il Teatroinaria a Lisbona, con l’Aiace Multirifrazione di Luigi Cinque in Senegal, con la Zattera di Babele a Vienna e in Olanda. Con l’Autunno Musicale abbiamo portato la nostra ricerca sul futurismo a Francoforte, a Praga e a New York.
Poi è cambiato qualcosa. Da una parte l’Italia è rimasta indietro come capacità di progettare. Dall’altra parte la danza in Italia si è trovata isolata, senza strutture di riferimento.
Tutto quel mondo che aveva affiancato i coreografi degli anni ’80 si è dissolto. A un certo punto il Teatro Sperimentale ha perso interesse per il movimento, è tornato alla parola. La musica ha ricominciato a viaggiare da sola.
E ora gli organizzatori appassionati di un tempo non ci sono più: penso a Roberto Cimetta, a Giuseppe Bartolucci. Sono arrivati gli Enti di Promozione… i bandi… il web…
Anche le mezze pagine su Repubblica non ci sono più. E le istituzioni hanno stretto la cinghia in maniera indiscriminata, senza considerare che era invece il momento di sostenere alcuni settori in grado di creare un ponte tra l’Italia e l’Europa.
Non è un bello scenario per chi torna adesso in Italia dall’estero. Una persona come Giovanna Velardi nel passaggio da Marsiglia a Palermo credo abbia dovuto ricominciare daccapo… e la sua battaglia convinta per le risorse ai progetti, per l’inquadramento sociale del danzatore, non sono andate lontano…
Mi chiedi se la responsabilità sia solo della classe politica… naturalmente no. Diciamo che, se la classe politica avesse uno straccio di progetto sulle questioni della cultura, questo aiuterebbe…
Anche il fatto di chiedere continuamente dei numeri per saggiare le capacità degli operatori, non depone a favore di una visione illuminata…
Ma poi c’è tutto il resto che non ha retto l’impatto con i nuovi media, o meglio con l’omologazione e l’inerzia che derivano da un consumo eccessivo di prodotti virtuali…
Forse tra un po’ non si andrà più nemmeno a scuola. Si passerà la vita su facebook.. incollati all’i phone.. anche i danzatori potranno imparare direttamente a casa le coreografie di Forsythe..
Non so perché ci sia questa attrazione a imbuto verso il web. Da una parte accelera la comunicazione, l’accesso ai dati.. ma dall’altra è la morte della relazione.
Nel secolo scorso si credeva nei viaggi, nei maestri, nell’esperienza diretta e prolungata nel tempo. Poi qualcuno non tornava nemmeno più. Metteva radici nel paese dove c’era uno spazio per la sua ricerca. Penso a Paco Decina, Enrico Tedde, Francesco Scavetta.
Negli anni ’90 chi era in cerca di maestri non partiva più verso gli Stati Uniti, ma verso la Germania, la Francia, il Belgio o l’Olanda. Poi le scelte si sono più diversificate. Ora si va anche in Spagna o in Grecia per una serie di jam, o in Giappone a studiare con un maestro di Butho. Così tra i nuovi autori c’è chi conosce il Metodo di Jean Cebron, chi è più legato all’universo della Contact. Tra i giovani è diffusa la pratica dell’Aikido, e girano varie tecniche di Floor Work. Questo crea corpi più dinamici. Rischio. Spettacolarità. Poi ci sono danzatori che vengono dal circo, altri che hanno fatto break dance o hip hop. Molti coreografi si avventurano nell’esplorazione dell’interattività, sistemi di motion capture, elaborazioni computerizzate, progetti fortemente interdisciplinari, ecc..
Si è alzato il livello degli interpreti e c’è una mobilità tra i paesi, favorita anche dal sostegno dell’Europa.
Oggi è tutto meno leggibile, meno necessario, meno profondo, ma potenzialmente più ricco.
Una risposta-racconto la tua molto ricca e fertile. Di molte cose di cui tu hai parlato, naturalmente in maniera sintetica, si potrebbe conversare a lungo.
Vorrei provare ad elencare qualcuno di questi aspetti, aggiungendo qualcosa anche io, fermo restando che questa rubrica si sta occupando e continuerà ad occuparsi di questi temi, continuando un viaggio il più possibile “aperto”.
Prima di tutto, vorrei parlare di questo sentimento avventuroso che permea il racconto della tua formazione. Credo che sia una questione fondamentale: non può esserci una formazione autentica senza l’avventura. Quell’avventura esteriore ed interiore che si nutre della magia degli incontri con luoghi e persone e che alimenta il sentimento dell’infinità possibilità.
Una vera formazione, scelta, voluta, appassionata deve, a mio parere, procedere sul filo paradossale dell’abbandono: quello di poter trovare un’altra cosa, un’altra disciplina, un altro paese, un altro modo diverso da quello che stiamo vivendo. Altrimenti la formazione non solo è noiosa ma non ci mette in gioco. Naturalmente l’intimità dello studio ha bisogno anche di una profondità verticale, di una concentrazione e di un isolamento intenso. Ma se negli anni della formazione un artista impara ad oscillare, tra focus interno e focus esterno, tra essere e non essere, allora forse questo imprinting resterà nel suo percorso a lungo.
Secondo, l’importanza dei maestri che oggi non c’è più, come tu dici. Abbiamo ucciso non tanto i maestri quanto l’idea di confrontarsi con loro. Siamo nell’epoca dell’assenza del padre e in cui le madri ondeggiano tra rivendicazioni e sensi di colpa, sensibilità e apatia restando comunque sempre troppo rassicuranti e protettive; e così i figli hanno dei bersagli o troppo in movimento o troppo evanescenti. Non voglio essere superficiale e la filiazione artistica ha logiche diverse da quelle famigliari, tuttavia credo che si possa riconoscere in generale che il confronto-scontro generazionale è diventato sempre più difficile (e sterile), quasi assente, paradossalmente, proprio perché i “ruoli” si sono troppo avvicinati.
E poi questo soggettivismo-relativismo senza fondamento, che non ha attraversato il mare dell’oggettività, che ha perso il senso graduale e quello gerarchico (di una gerarchia intelligente e stimolante, non inibente) ha creato individui sempre più soli che soffrono di qualcosa che non riescono, forse, neanche più a riconoscere, rispetto a noi. Come se il vuoto fosse un istinto sepolto che a volte esce e reclama la sua preda, una nostalgia di un altrove mai conosciuto o vissuto. Un legame che mi ricorda i replicanti di Blade Runner…
La terza cosa di cui mi piacerebbe parlare è la ricchezza degli orientamenti della cultura italiana di quegli anni. Il Novecento è stato un secolo molto intenso, lo sappiamo, ma in quei trenta quaranta anni del dopo guerra, l’Italia ha espresso una complessità e una ricchezza tali che forse… ora siamo molto stanchi, molto provati, come lo si è, semplicemente ed organicamente (per citare questi due bei aggettivi che hai usato all’inizio della tua risposta), dopo un lungo e forte sforzo. Una ricchezza che coniugava il reale e l’astratto, la fede e il dubbio, l’amore e il non amore, la pesantezza e la leggerezza, la commedia e la tragedia, l’io e la collettività etc…
Anche io ho studiato e lavorato con Quartucci e la sua zattera, ed è stato avventuroso e appassionante, doloroso ed eccitante, è stato un lavoro complicato uccidere questo padre tanto vitale quanto assente, già corrotto da quello che sarebbe a breve accaduto (dunque artefice egli stesso), eppure ancora abitato da una febbre meravigliosa. Pensando a quegli anni, al suo concettualismo già un po’ sordo, mi viene da dire che il concettualismo senza una temperatura intorno è inutile.
Il concettualismo, che si fonda non solo sull’assenza di qualcosa o sul presentimento di un’altra realtà, mentale o divina non importa, senza una realtà viva, senza un’atmosfera interessante e interessata, diventa forse mero esercizio formale, piuttosto innocuo.
E questa perdita di interesse della società italiana per l’arte a chi la si deve? Le risposte sono tante ma certo quest’assenza dei critici, questa perdita di figure come quelle che hai citato (e altri se ne potrebbero fare) è un segno della generale perdita progressiva della capacità di ascolto. Per essere dei testimoni, dei “curatori”, degli insegnati, per “tradurre”, bisogna prima ascoltare con attenzione e questo è venuto meno. Aldilà dell’intelligenza dei critici di oggi, della loro preparazione e passione, che, mediamente, sono assai inferiori rispetto a quelle del passato, è venuto a mancare, semplicemente, l’amore per gli artisti, l’ascolto profondo della loro opera e della loro vita. Certo, già ai tempi degli inizi di Grotowsky e Bene, di Pina Baush e Kounnelis, i critici erano artisti mancati, spesso invidiosi e desiderosi di potere. Ma col tempo questa tendenza della personalità è diventata una nevrosi normale, sciogliendosi nella più generale malattia sociale.
Altro argomento importante che tocchi, infine, è l’Europa. Vorrei uscirmene con una domanda: e se invece di fare la moneta unica avessimo fatto (prima) una televisione europea, priva di pubblicità magari, nella quale programmare format culturali e di costume creativi ed intelligenti? Dove ospitare i giovani degli erasmus e i vecchi della prima e seconda guerra mondiale, insomma tutte le generazioni, una televisione culturale capace di mettere insieme le più significative esperienze di ogni paese, ma che non si fermava agli anchor man, alla ripetizione sedante e che invece “trasmetteva” continuamente un movimento, una circolazione antica e nuova, riflettendo la sua identità liquida eppure stratificata (frutto di una civiltà così ricca); se l’Europa avesse fatto questo che cosa sarebbe successo?
Certo è una domanda piuttosto ingenua…
Quindi è meglio tornare a temi a noi più consoni. E pensando a quella battuta che hai fatto sulla musica che si è allontanata dalla danza, segno forse della perdita del corpo della musica (inutilmente arginato dai ritorni alle musiche e balli tradizionali che, come ho scritto in un mio precedente articolo ispirato dalla scomparsa di Ray Manzarek, celebrano un’isteria di massa che non trova redenzione o catarsi sufficienti) ti chiedo:
perché il teatro sperimentale è tornato alla parola e la musica ha viaggiato da sola, secondo te? E questa interdispiplinarietà contemporanea, che soprattutto vuole l’uso del video e della tecnologia, che cosa ha portato alla danza? O ha tolto?
Esiste oggi un performer, un interprete, direi anche un corpo (intendendolo nel senso più ampio) che ha interiorizzato veramente le dinamiche degli altri linguaggi creativi, che ha sedimentato ed elaborato i tentativi (e i fallimenti) delle avanguardie storiche e dell’atmosfera creativa degli anni “60 e “70? Faccio un esempio più pratico: esiste un danzatore che, aldilà dei proclami, sa lavorare davvero con lo spazio, che sa diventare campo lungo e primo piano, che sa custodire lo sguardo del pubblico, portandoselo in giro, come diceva con una felice espressione Anna Paola Bacalov, (danzatrice che ha lavorato sia con me che con te e che cito dunque non a caso)?
Che sa diventare informale o formale, ritmico o melodico, tonale o seriale, nel processo immaginativo ancor prima che nel movimento? Che sa attaccare il pubblico (come incitavano Picabia e Tzara nel loro manifesto) e difendersi consapevolmente e non egoisticamente (come suggeriva Kantor), che sa offrirsi e usarsi, che sa diventare bianco e smarrito e poi acceso e ubiquo, che sa essere e non essere?
O piuttosto il corpo, in questo inizio di millennio, celebra la sua sconfitta anche se creativa e indomita (simile a quella di un dinosauro che continua a sbattere il corpo con violenza per non farsi congelare) nel momento in cui si fa prendere e riprendere dalla tecnologia?
Un’altra volta siamo sulla stessa lunghezza d’onda… credo anch’io che il corpo abbia perso terreno nei confronti della tecnologia. Non tanto perché non ci sia più un corpo “sapiente”, ma perché non c’è più nessuno che lo guarda. Non solo nella danza, ma in generale nella vita di tutti i giorni. E non è un passo avanti… Nel raccontare dico e basta. Non interpreto e non approfondisco, ma questa convinzione emerge dalle mie risposte, da come individuo i fatti e li metto in fila.
Non capisco perché incentivare nell’arte e nelle politiche di sviluppo ormai soltanto l’uso delle NUOVE TECNOLOGIE… Addirittura con una pioggia di finanziamenti pubblici…!!!!
Se penso ai prodotti artistici “tecnologici”, per un’opera egregia e necessaria, quante ce ne sono che non lo sono affatto? Osservo che in palcoscenico, ma perfino al cinema, l’uso facile della tecnologia, quando addirittura non rappresenta per l’autore una vera e propria scappatoia, uccide i corpi vivi e a lungo andare crea un vero e proprio logoramento… una saturazione… una nausea… una distanza…una voragine percettiva.
Lo zapping, nato per divertimento o per noia, sta generando una mutazione epocale. Quanti bambini soffrono di un disturbo dell’attenzione? Quanti adolescenti faticano a trovare un centro? E un senso nella loro vita? E il problema non è il lavoro che non c’è…
Vedo ogni anno passare di qui molti studenti e molti danzatori. E vado a vedere qualche spettacolo ogni anno all’Auditorium. Giuro che anche senza spostarmi troppo, anche solo da qui, da questo piccolo paese dove si incontrano tante persone, posso accorgermi benissimo dell’esistenza di tanta gente che lavora bene. Potrei farti decine di esempi di interpreti giovani e meno giovani che hanno interiorizzato di tutto e di più, anche italiani… ma oggi questo interessa a qualcuno?
Quante persone dedicano tempo a guardare? Forse all’interno di una terapia di gruppo…
Forse la danza, il mondo della danza doveva fare di più in questi anni per arginare questa perdita del corpo. La danza ha un immenso potere sull’umanità. A mio parere bisogna riflettere sulla debolezza del mondo della danza contemporanea. Forse è successo qualcosa di paradossale: danzatori e coreografi si sono rinchiusi troppo nel movimento del corpo o nel suo assedio, nell’esprimere un disagio, e hanno contribuito a questa perdita. Se gli dei non vogliono più volare, non credono più di poterlo fare, allora anche gli uomini perdono la speranza.
Io amo Pina Bausch perché nel suo lavoro non c’è debolezza, c’è la forza di Stravinsky e del rock, l’alba nietzschiana e il crepuscolo felliniano, il mito e il presentimento, il dolore e l’amore, ma qui in Italia la danza ha avuto un altro carattere. Non vorrei tornare alla mia domanda della prima puntata ma quella bella risposta che hai dato sulla debolezza-timidezza della danza italiana, e che parla degli aspetti “personali” di ogni artista (così importanti), può anche portare ad una considerazione, forse eccessiva, sulla nostra incapacità di vivere e di morire con coraggio.
Il teatro, specchio implacabile, può rivelarci questo. Il teatro profondo, aldilà dello spettacolo, può mettere in scena il saper vivere e il saper morire. Se il teatro, prima di tutto, ha coraggio. Non lo dico con toni d’annunziani ma semmai semplicemente politici. La danza poteva essere rivoluzionaria, poteva (e sempre può) cambiare le nostre esistenze.
Così ti chiedo, infine, un pensiero sulle parole e la danza.
Quando si pensa alla danza si pensa al corpo, ma aldilà delle tecniche e degli stili espressivi che si usano, pensi che sia necessario raccontare la danza anche con le parole ad un pubblico che appare sempre più sordo di fronte alla ricchezza e alla complessità del corpo? Se si, in che modo?
Certo che si debbono usare anche le parole, poche parole, semplici e incisive. Nei programmi di sala. Magari in un’intervista radiofonica. Se c’è l’occasione, un po’ di domande al termine dello spettacolo.
Si potrebbe parlare di danza in contesti diversi. Nel corso di una conferenza che traccia il quadro di un’epoca, o racconta l’evoluzione di un genere. Credo il supporto dei mezzi audiovisivi sia indispensabile. La danza innanzitutto bisogna vederla. Poi ci sono diversi livelli di lettura, come per un quadro, un libro o una partitura musicale. Si può rimanere in superficie, tracciare delle linee-guida per cominciare a vedere le differenze. Si può andare più in profondità. Nel 1998 abbiamo organizzato a Tuscania un convegno. Si chiamava “leggere il pensiero danzato”. Varie persone erano invitate a vedere in una mattina tre diverse coreografie ed erano invitate a scrivere quello che vedevano. Poi si leggevano gli appunti degli spettatori e cominciava un confronto tra gli artisti e il pubblico, con la mediazione di un “esperto” che in quel caso era Ada D’Adamo, avendo a disposizione il video appena girato per entrare nei dettagli quando serviva.
Più recentemente Giorgio Testa, nel gruppo di osservatori creato a Tuscania all’interno del Progetto Eti “Spazi per la Danza Contemporanea”, ha coinvolto un piccolo gruppo di persone a seguirlo nella sua esplorazione “marziana” di un’arte che non conosceva e ha trovato insieme a loro concetti e parole per comprendere e valutare questi “oggetti misteriosi” che arrivavano qui.
C’è qualcuno, come Carlo Locatelli, che si è posto il problema di dare la parola al movimento e si diverte a fare delle conferenze danzate. In una di queste è nudo e parla dell’anatomia e della sua coscienza del corpo.
I Labanisti hanno sempre parlato di approccio pratico-teorico per comprendere la logica del movimento come linguaggio. Anche l’universo del Body-Mind Centering può offrire preziosi strumenti di conoscenza e analisi, con il suo approccio esperienziale e la sua coscienza del senso.
In fondo non ci vuole molto a entrare nell’analisi del movimento. Sono concetti elementari. Una dimostrazione dal vivo può essere molto utile. E una sperimentazione personale magari nel corso di un breve laboratorio ancora di più. Credo infatti che il mezzo più efficace per comprendere la danza sia danzare. Quantomeno muoversi. Fare esperienza del come e del perché.
Anche gli studi degli artisti possono giocare un ruolo in questo senso. Gli studi non sono “le scuole”. Non hanno obiettivi commerciali e di numero, ma culturali e di ricerca. Molte persone della mia età hanno aperto uno studio. Penso ad Ariella Vidach e al Did Studio di Milano, a Roberto Cocconi, che ha creato a Udine Lo Studio, a Virgilio Sieni che ha creato Cango a Firenze. Ma ci sono stati altri: Rossella Fiumi a Orvieto, Roberto Zappalà a Catania, lo Studio Blu di Alessandro Certini a Sesto Fiorentino, la Chiesa di Spello della Sosta Palmizi, Vera Stasi a Tuscania con il Supercinema, Roberto Castello con Spam a Lucca, Caterina Genta a Spoleto con il Cantiere Oberdan, la Oplas a Umbertide, il Duncan a Roma. E molti altri che io conosco di meno, ma che esistono… Tutte queste realtà svolgono già una funzione molto incisiva nell’aiutare a guardare la danza, nell’aiutare a pensarla… Sono centri attivi da cui possiamo aspettarci molto.
Bene aspettiamocelo allora. La nostra storia non è finita. Siamo stanchi, certo, ma il corpo sa come fare. E se il corpo sa… saprà trovare la sua strada… Magari anche la nostra morte sarà una bellissima danza, se riusciremo a guardarla…
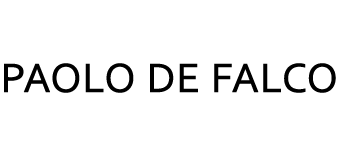
Lascia un Commento