La redenzione del tango
Non si può insegnare un desiderio, ma si può suggerire a qualcuno di muoversi ed esplorare. Il tango può indicarci la strada tra l’essere e il non essere.

Riprendiamo la conversazione con Samantha Di Paolo, ballerina e insegnante di tango argentino. Chi avesse perso la “puntata” precedente, può naturalmente trovarla qui accanto o cliccando sotto, alla voce Il mercato del vento, titolo di questa rubrica, accedendo al suo archivio con tutti gli articoli.
Samantha ci ha raccontato la sua visione del tango e di come sta tentando di usarlo vivendolo e considerandolo un linguaggio “aperto”, un linguaggio denso e  articolato che predispone e necessita di una sensibilità scenica e artistica profonda.
articolato che predispone e necessita di una sensibilità scenica e artistica profonda.
Provando quindi a non rimanere imprigionata dalla sua dimensione tecnica o formale, ma esplorandone, invece, i suoi diversi livelli, le sue sfumature, anche in chiave terapeutica.
Continuo a farle delle domande, allora, per viaggiare insieme a lei dentro questo universo del tango che continua ad affascinare tante persone…
Allora Samantha, tu hai vissuto a lungo a Buenos Aires e hai sposato un musicista argentino di tango. Che differenza c’è tra il tango di lì e quello italiano? Mi riferisco a come lo si balla, ma più in generale a come lo si vive. E cosa pensi di questa continua devozione nei confronti di Buenos Aires che, devo dire, io trovo piuttosto provinciale e a volte proprio fastidiosa… Naturalmente non si può non riconoscere che il tango porteno sia speciale, che gli argentini lo ballano benissimo e che questa mitica città, nata con l’emigrazione, sia stata e continui ad essere, per molte ragioni, la culla, l’habitat ideale per il tango. Ma non è forse interessante vedere come ogni cultura e luogo vive e interpreta diversamente il tango? Come un linguaggio diventi patrimonio dell’Umanità proprio in quanto riesca a viaggiare, a radicarsi altrove, a mischiarsi diventando, appunto, uno strumento e non un fine?
La differenza tra il modo di vivere il tango a Buenos Aires o Montevideo rispetto ad altrove è nel percepirne l’insieme come cultura. Il tango a Buenos Aires non è solo un ballo di coppia.
Ad esempio, della mia famiglia argentina, sia paterna sia acquisita, nessuno è milonguero (frequentatore di milongas e quindi ballerino sociale), ma ho uno zio molto tanguero, nello spirito. Nel modo di essere, anche ironico, disincantato ma fondamentalmente drammatico.
Normalmente a Bueonos Aires conoscono i personaggi importanti del tango, i parolieri, qualche testo importante, e la musica passa in radio o per le strade fuori dai negozi di dischi per attirare i turisti, e quindi alla fine entra “dentro”. Tra i taxisti ci sono molti tangueri, è un classico. Ascoltano tango ma magari non lo ballano affatto. Ci sono i musicisti, ma quello che ho sposato io no, non è affatto realmente tanguero, la sua cultura musicale è molto rock e pop, ma il tango gli appartiene comunque per averlo assimilato perché è parte del “pulso” di Buenos Aires.
 Il tango è nei suoi caffé ad angolo, nella frenesia, negli incontri fugaci e mancati, nella nostalgia che guarda altrove di un luogo che come genius lociha la malinconia indefinita. Sempre fuori tempo, sempre fuori luogo. Certo, anche a Buenos Aires il marketing del tango ha lavato via buona parte dell’autenticità di una tradizione. Però è chiaro, per capire davvero il tango, bisogna conoscerne la cultura, viverla a fondo e durante un certo arco di tempo. Vivere anche le esperienze che si passano guadagnandosi da vivere a Buenos Aires, in piena precarietà.
Il tango è nei suoi caffé ad angolo, nella frenesia, negli incontri fugaci e mancati, nella nostalgia che guarda altrove di un luogo che come genius lociha la malinconia indefinita. Sempre fuori tempo, sempre fuori luogo. Certo, anche a Buenos Aires il marketing del tango ha lavato via buona parte dell’autenticità di una tradizione. Però è chiaro, per capire davvero il tango, bisogna conoscerne la cultura, viverla a fondo e durante un certo arco di tempo. Vivere anche le esperienze che si passano guadagnandosi da vivere a Buenos Aires, in piena precarietà.
Succede che non tutti gli argentini ballano bene. Non c’è una ragione antropologica chiara per la quale dovrebbe essere così. E’ una questione culturale e non ha a che vedere con il talento della danza. In realtà, la vera differenza ha a che fare con l’attitudine. L’attitudine sottilmente, e a volte neanche tanto sottilmente, arrogante. L’attitudine arrogante che maschera la ricerca di appartenenza. E la necessità di sapersi furbi e in grado di fregare prima di essere fregati.
La fregatura è sempre messa in conto, la si dà per scontata. In tutte le relazioni orizzontali o verticali. Credo somigli a Napoli, sì… somiglia decisamente a una certa energia napoletana. Che è sbarcata lì. Ed è l’energia del disordine, del meticciato, dell’umorismo nero. Poi, esistono infinite barzellette sul narcisismo argentino.
Ciò che attrae quindi lo straniero è questa attitudine. E nel momento in cui devi entrare in un’arena a esibirti, senza questa arroganza, potresti essere perduto.
Ora, la differenza sta quindi nell’isolare del tango solo la danza. Personalmente ritengo che non si possa prescindere dal contesto di una creazione popolare, isolandone un solo elemento. Il fenomeno “moda” del tango in Europa, che insieme con quello porteno è quello che conosco meglio, non mi convince affatto. Non sono d’accordo con l’atteggiamento reverenziale né con l’ansia imitativa acritica delle milongas di Buenos Aires ma sapere il perché di una certa espressione sociale per me è fondamentale. Certi “codigos” ovvero regole di comportamento, hanno un perché ben preciso e spesso sono di aiuto al tango. Come, ad esempio, la “mirada”. La mirada è l’invito non verbale, attraverso lo sguardo. Vale sia per la donna che per l’uomo e afferma la libertà di scegliersi piuttosto che di subire un invito non gradito in quel momento.
Un’altra cosa che rilevo come differenza nel tema della riverenza è il fraintendimento che accade nella scelta della musica. Spesso per atteggiamento di devozione in Europa si sceglie musica che a Buenos Aires non ballano neanche. Lo si fa per un eccesso di tradizionalismo e severità… quando invece a Buenos Aires la scelta della musica risulta essere più libera, anche all’interno della tradizione.
Ogni luogo riceve e trasforma in ogni caso inevitabilmente un fenomeno culturale, e questo è naturale e interessante. Però, per me, sono le intenzioni che contano. Ad esempio,  nell’Europa nordica sono più composti e attenti allo studio del movimento e magari anche all’ascolto della musica, s’ impegnano e il livello di ballo cresce di livello. Ma manca attitudine. In Italia invece c’è molto glamour, una tensione simile a quella che si respira nelle milongas di Buenos Aires, ma poca dedizione tecnica al ballo. Beh, in fondo, le eterne differenze. Dopotutto molto dell’attitudine italiana fa parte del tango. Molto del suo genio anche. Basta studiare, appunto, la cultura del tango.
nell’Europa nordica sono più composti e attenti allo studio del movimento e magari anche all’ascolto della musica, s’ impegnano e il livello di ballo cresce di livello. Ma manca attitudine. In Italia invece c’è molto glamour, una tensione simile a quella che si respira nelle milongas di Buenos Aires, ma poca dedizione tecnica al ballo. Beh, in fondo, le eterne differenze. Dopotutto molto dell’attitudine italiana fa parte del tango. Molto del suo genio anche. Basta studiare, appunto, la cultura del tango.
C’è una controtendenza europea alla riverenza verso l’argentinità tanguera… si basa sull’isolare l’elemento “danza” del tango da tutto il resto, aggiungere molto glamour comunicativo sociale, una certa quota di “esclusività” agli eventi. Il glamour inevitabilmente opera un’esclusione piuttosto che un’inclusione e si perde molta della spontaneità popolare di questa espressione creativa. Questo non mi piace, perché si esclude il fattore cultura in senso ampio.
Il tango non come espressione folcloristica ma come linguaggio artistico appartiene senz’altro all’Umanità intera, perché umani e universali sono i contenuti che indaga ed esprime. La tematica della ricerca di un senso di appartenenza, il senso della perdita, la lotta per la sopravvivenza, la sofisticazione del dolore, la ricerca di contatto con l’altro e il pulsare del maschile e femminile.
È molto interessante quello che dici sull’attitudine e anche sul rapporto con Napoli. Capisco cosa tu voglia dire quando parli di questa sottile arroganza che maschera la ricerca di appartenenza. Credo sia molto importante questo aspetto e vorrei aggiungere qualcosa.
Ho lavorato per un po’ a Buenos Aires e viaggiato in Argentina e sono d’accordo che molto del fascino di questa città deriva da questa atmosfera insieme eccitante e malata, febbrile e sfinita, forte e debole. E che questo derivi dalla patologia dell’emigrazione, dal suo intreccio di desiderio e di nostalgia, di amore per la radice ma anche per la frontera.
Ho fatto un film su Buenos Airesche si chiama Stella loca che finiva nell’Hotel des Inmigrantes, luogo dove un tempo sostavano tutti gli immigrati appena arrivati, e lo faceva restituendo la soggettiva di uno sguardo perso nel buio di quelle stanze superiori dell’Hotel, abbandonate da tempo, che si ergono su quelle dei  primi piani dove, ora, il Governo argentino ha “costruito” il suo Museo dell’emigrazione.
primi piani dove, ora, il Governo argentino ha “costruito” il suo Museo dell’emigrazione.
Lo sguardo proveniva, in verità, da un percorso-smarrimento nel Palazzo Barolo, uno degli edifici più importanti di Buenos Aires, costruito da un architetto italiano (Mario Palanti) e ispirato alla Divina Commedia di Dante. Un palazzo che, per diverso tempo, è stato l’edificio più alto dell’America Latina, quello da cui guardare più lontano.
Così, da una piccola porta in cima alle scale, lo sguardo passava dai tre regni “ultraterreni” del Palazzo alle scale polverose dell’Hotel des Inmigrantes, perdendosi gradualmente nel buio della notte. Fino a trovare una sola via d’uscita: quella di ballare da solo nell’oscurità.
Il film finisce con questa danza che resta sospesa tra il nero dell’interno e la luce diafana del fuori, tra l’archivio dimenticato di tutte quelle carte abbandonate a terra con i nomi degli emigrati passati lì, e i grattacieli di fronte avvolti dalla nebbia, come un paesaggio “rubato” al futuro o più semplicemente al terzo millennio.
Racconto questo per dire che non si può sentire Buenos Aires senza percepire questo “passaggio”. In quell’Hotel, anche se quasi nessuno lo ha scritto, è nato il tango. Le stesse grandi, lunghe e vuote sale dell’Hotel ispirano camminate coraggiose capaci di affrontare la sfida del vuoto. Camminate solitarie che anelano a trovare la resistenza, il contenimento di un altro corpo o di un altro stato. A trovare una via di fuga o una salvezza.
Quello sguardo era quello di una giovane donna italiana, come te, che era giunta lì dopo un suo errare disordinato ma preciso, come obbedendo ad una volontà segreta della città. Un’anima femminile (che potrebbe appartenere anche ad un corpo maschile) capace di accogliere e di avvertire la magia e il pericolo di Buenos Aires, mentre si chiede se emigrare o restare nel suo paese. Un’anima capace di ricordare e di dimenticare tutto nello stesso tempo, che si lascia muovere da qualcosa d’invisibile e di liberatorio, mentre procede con ostinazione e con coraggio, incatenata solo ai suoi passi nel buio e alla sua stella loca… lassù.
Del resto molte donne italiane da alcuni anni si perdono a Buenos Aires con la “scusa” del tango, cercando un abbandono che forse, altrove, non riescono più a  trovare.
trovare.
Vorrei anche aggiungere che questa arroganza che maschera la ricerca di un’appartenenza ha forse, come dici, a che fare con Napoli perché Napoli ha radunato il fallimento dell’Italia.
Uno storico, Guido Crainz, ha chiamato, tempo fa, un suo libro sulla storia italiana Il paese mancato, perché è innegabile che il nostro sia un paese che non è ancora riuscito ad “unirsi”. Napoli, candidamente avrebbe detto Pasolini, contiene questo fallimento e lo risolve a modo suo, con un’arroganza capace non solo di sopravvivere ma anche di ignorare l’arroganza di chi non ha l’anima per sentire la bellezza del fallimento. La resa, del resto, è per gli “scalognati”, per i miserabili, per i perditempo. Coloro che, alzando o abbassando le mani, si consegnano al tempo senza neanche saperlo…
Si, il tango esprime essenzialmente una poetica della migrazione. La migrazione tra il dentro e il fuori, tra il lontano e il vicino, tra il ricordo e il presente. Buenos Aires contiene la poetica, il dolore e il riscatto della migrazione nelle sue fondamenta.
E a me risuona moltissimo tutto questo, perché la mia vita personale è in una condizione di nomadismo costante. Di ricerca di radici che non ho avuto concretamente ma che ho dovuto inventare e ricercare. E di incontro continuo con una frontiera. Sono figlia di emigrati, nata all’Estero, non in Italia. Non mi apparteneva assolutamente il mio luogo di nascita, mi sentivo sradicata e legata a un’Italia idealizzata che vedevo solo 5 settimane l’anno d’estate e che anelavo. Studiavo la lingua e la storia della mia cultura-appartenenza solo un giorno alla settimana. Non volevo fare altro che tornare. Ma poi, tornando, ho realizzato che ormai l’inquietudine mi si era impressa dentro come un calco e che avrei continuato a cercare il luogo della mia appartenenza per il resto della mia vita. Ne parlo perché è un piccolo intimo dramma che ha influito sicuramente nello svolgimento della mia vita personale e professionale, nell’incontro col tango.
 Forse per arrivare a capire o a sentire che la mancanza non è un dramma ma un’opportunità, una ricchezza, che l’emigrazione, fondamentalmente, amplia il nostro destino più che ridurlo, lo rende più fertile e più vicino all’essenza della vita, alla sua meravigliosa vanità, bisogna “ballare” molto, fare molti km… Finché, piano piano, le radici si svelano (o si trovano) dove erano sempre state…
Forse per arrivare a capire o a sentire che la mancanza non è un dramma ma un’opportunità, una ricchezza, che l’emigrazione, fondamentalmente, amplia il nostro destino più che ridurlo, lo rende più fertile e più vicino all’essenza della vita, alla sua meravigliosa vanità, bisogna “ballare” molto, fare molti km… Finché, piano piano, le radici si svelano (o si trovano) dove erano sempre state…
Per ultimo, vorrei chiederti: il tango è un mondo che per molti versi si può considerare piuttosto maschilista. Questo sta cambiando o perdura staticamente? In tutti i casi una donna come può esprimersi in questo ambiente (anche nell’insegnamento) senza reverenze e sottomissioni al maschio?
Parlando di machismo, tocca analizzare il tango nella sua complessità culturale. E’ certo che l’immagine femminile dei testi tradizionali del tango rimanda a una condizione di passività. Del resto, è storia dell’umanità, niente di nuovo. Le donne come sempre venivano divise nei due grandi filoni della martire e della puttana, come da cultura giudaico-cristiana. In fondo questa doppia lettura inconscia, perché non più politically correct, permane sottilmente anche nei nostri giorni.
Nei testi tangueri c’è la madre, la povera madre che è tutta sacrificio e nostalgia. La madre che come il “barrio”, il quartiere, è un canto alla nostalgia. E c’è la donna che da virtuosa fa un passo falso e cambia la sua sorte di poveretta e dignitosa, per diventare oggetto sessuale, a causa di un amore infausto per un uomo che la sfrutta e la vende. C’è la donna sensuale che si districa nella girandola della vita viziosa e che affascina, incanta, abbandona. O viene uccisa dal suo uomo geloso.
Per il tema del femminicidio c’è un tango che si intitola “Un crimen”, nel quale l’uomo in questione descrive poeticamente come ha strangolato la sua amante innocente in un accesso di gelosia:
Y vi neblina en sus ojos
Cuando mis dedos de acero,
En su cuello de nácar
Bordaron un collar.
Rodó besando mis manos
Y apenas pudo gritar,
Su voz se ahogó sin reproche
Y así mansamente, tuvo fin su noche.
Tengo su angustia en mis ojos
Y no la puedo arrancar.
E vidi nebbia nei suoi occhi/quando le mie dita di ferro/cinsero una collana/nel suo collo candido. Si accasciò baciandomi le mani/appena poté gridare/la sua voce affogò senza un rimprovero/ e così, mansueta/trovò fine la sua notte. Ho la sua angoscia nei miei occhi/ e non la posso staccare.
rimprovero/ e così, mansueta/trovò fine la sua notte. Ho la sua angoscia nei miei occhi/ e non la posso staccare.
Un altro testo molto forte che si intitola “Confesion” recita:
Fue a conciencia pura,
que perdí tu amor,
nada más que por salvarte;
hoy me odiás y yo feliz,
me arrincono pa’llorarte.
El recuerdo que tendrás de mí,
será horroroso,
me verás siempre golpeándote,
como a un malva’o;
y si supieras bien, que generoso,
fue que pagase así,
tu gran amor.-
Sol de mi vida,
fuí un fracasa’o;
y en mi caída,
busqué de echarte a un la’o.
Porque te quise tanto,
tanto, que al rodar;
para salvarte,
solo supe hacerme odiar.-
Fu con piena consapevolezza/che persi il tuo amore/solo per salvarti/oggi mi odi e io felice/mi nascondo per piangerti.
Il ricordo che avrai di me sarà orribile/mi vedrai sempre picchiandoti/come un bastardo/e se solo sapessi, che generoso/fu che io abbia pagato così/il tuo grande amore.
Sole della mia vita/sono un fallito/ e nella mia caduta/ ho voluto lasciarti da parte/
Perché ti ho amato tanto/tanto che cadendo/per salvarti/solo seppi farmi odiare.
Pensare che balliamo abbracciati testi del genere dà da pensare al fatto che stiamo danzando su una relazione malata e ferita tra uomo e donna che però cerca una redenzione. E la redenzione è offerta proprio dalla danza di coppia del tango, da quell’abbraccio, da quell’infinita complessità.
La genesi del tango contiene, d’altra parte, se parliamo di maschilismo, una matrice di dolore e perversione nella relazione col femminile. La storia del tango in qualche punto si intreccia con il fenomeno dell’importazione di prostitute dall’Europa, anche definita come tratta delle bianche.
La storia delle tratte la conosciamo tutti ed è sempre sostanzialmente uguale a se stessa nei secoli e nei luoghi: l’inganno, lo sfruttamento, la violenza, la violazione dei diritti elementari, lo svilimento della persona, la morte.
Impossibile ignorare una simile potente cellula dell’insieme.
Comunque, parlando del ballo, credo ci sia un fraintendimento di base sui ruoli del tango, che percepisce attivo il ruolo di chi porta, quindi quello maschile, e passivo il ruolo di chi segue, quindi quello femminile.
La questione è complessa e delicata, ma sostanzialmente la verità è che entrambi i ruoli sono attivi. Ma in modo diverso. In modo complementare. La redenzione è nel lasciar brillare la bellezza della differenza. Poiché l’incontro reale può solo avvenire nel riconoscimento assoluto della potenza di entrambe le facce di una stessa medaglia. L’incontro avviene nella differenza e nella collaborazione per ricreare il paradiso perduto dell’unità, dell’appartenenza.
Credere che seguire sia passivo è un fraintendimento che avviene spesso. Alcune donne si ribellano e non ne vogliono sapere, e quindi resistono irrigidendosi. O fuggono. Da parte loro, alcuni uomini credono che portare significhi trascinare un altro corpo con la forza e piegarlo al proprio volere, o correggere sempre e comunque la donna. Alcune donne si abbandonano a peso morto in un’illusione di mancanza di responsabilità e si lasciano trascinare qua e là. Ebbene, questi sono tutti fraintendimenti di cosa sia realmente ballare tango.
Ballare un tango significa avere ben chiaro il dispiegarsi della propria creatività dalla propria metà dell’abbraccio, al servizio, e dico al servizio, della creazione comune. Non può esserci competizione. Sebbene avvenga spesso, in particolare tra professionisti, che uno dei due voglia brillare più dell’altro. E allora si vedono ballerini che girano intorno e sorreggono ballerine, o ballerine che girano intorno a ballerini persi in un monologo di destrezza autonoma e scollegata dalla coppia. Credere che questo sottotesto non venga percepito da chi guarda è francamente ingenuo. Non funziona mai quando è così, poiché ci sarà sempre la dissonanza della competizione o dell’uso dell’altro per i propri fini narcisisti. Viene fuori la rappresentazione artistica di uno squilibrio, che pure può dare da pensare.
Quando le cose funzionano, “portare” significa assumere su se stessi la responsabilità della direzione spaziale del movimento comune, comunicare con chiarezza dove si vuole andare con l’altro, cosa si vuole fare e quando. Significa assumere su di sé la gestione dello spazio intero e condiviso con le altre coppie, e la responsabilità dell’interpretazione musicale generale, ma non particolare e sottile. Significa offrire uno spazio di sicurezza a chi si vuole invitare a viaggiare con sé, accogliere nell’abbraccio, proteggere, e guidare senza soffocare. La chiarezza delle direzioni è il grande dono specifico maschile alla relazione danzante. Per essere chiari bisogna fare un grande lavoro. Ed è un lavoro di servizio. Un lavoro nobile. Non è forse tutto questo il principio maschile nel suo aspetto luminoso? L’attitudine alla gestione dello spazio, alla protezione, alla chiarezza delle direzioni? La linea? La decisione? Come donna non posso percepire questo come aggressivo e umiliante nei miei confronti, no. Perché se io che voglio, che scelgo di seguirti, accetto questo gioco, voglio sentirmi accolta e protetta, al sicuro tra le tue braccia, perché io non vedo dietro di me quando avanziamo insieme, e voglio potermi fidare di te.
Se tu sei la linea, io sarò il cerchio, il punto. E la divagazione creativa. Riceverò la tua linea e i miei piedi come frecce la manifesteranno, ma sono io stessa che decido di muovermi e lo faccio col mio modo personale. Con la bellezza della mia particolarità. Come donna, non solo ricevo, ma trasformo. Io non eseguo, io trasformo. E tu ricevi te stesso da me trasformato e a tua volta ti trasformi. E trasformare te ha trasformato anche me.
Tu attraversi me… come io te… e questo non ci lascia indifferenti. In tutto questo dialogo, nel frattempo, la musica c’ispira, lo spazio cambia ed esige adattamento continuo della nostra improvvisazione. Nella musica, io posso scegliere come muovermi, cosa prediligere di me nella mia espressione per te. Cosa voglio farti vedere di me. Posso rallentare, per farti sentire come sento, ma sarò duttile a seguire la tua nuova direzione. Così la libertà dell’uno e dell’altra entra ed esce nei reciproci spazi, tempi e ruoli con l’unico intento di creare un accordo tra due sensibilità. Un accordo costante, plastico e in continuo divenire, attimo per attimo.
Come vedi, il maschilismo rovinerebbe tutto. Nella danza del tango, la “funzione” uomo è strettamente connessa e interdipendente alla “funzione” donna. Perché si lavora insieme alla creazione di qualcosa che sta fuori di noi, una terza entità, una creazione artistica improvvisata e condivisa che è… un tango.
In quanto all’ambiente di lavoro, e allo spazio sociale della milonga, al di fuori della redenzione offerta dal ballare insieme, le dinamiche del maschilismo e del dominio si manifestano ancora.
E’ un ambiente molto duro in quanto la tendenza al glamour rende il corpo un oggetto. La donna deve spesso fare i conti con l’apprendimento dell’attesa. In realtà, attraverso il gioco della “mirada”, l’invito con lo sguardo, l’accordo non verbale, il suo ruolo in pista e nella scelta è del tutto pari a quello maschile. Ma accade che in molti luoghi fuori Buenos Aires non sia in uso questo strumento. E allora bisogna imparare ad aspettare mantenendo alto l’umore. Ma l’attesa può essere una opportunità per l’osservazione senza cedere all’impazienza del desiderio.
Le dure regole del glamour colpiscono anche la coppia di ballerini nel momento dello show: dare prova di destrezza, di eleganza, di bellezza. Rispondere a dei canoni estetici predefiniti. Ovviamente, come succede in generale in tutto il contesto sociale, la donna ne soffre di più. Il suo corpo deve essere giovane, bello, elastico, sensuale. I canoni estetici sono predefiniti. Ciò non toglie che si possa e si debba lavorare in una direzione di affermazione artistica, e l’arte ha sempre in sé una chiamata al servizio che trascende il glamour.
In quanto alla relazione coi compagni artistici, c’è da dire che in generale gli uomini hanno più difficoltà a mettersi in discussione. In particolare in questo ambiente nel quale la loro mascolinità è continuamente sotto pressione, così come, del resto, la femminilità per le donne. Di solito, tendono a ripetersi dei modelli, come ad esempio lo sfruttamento del lavoro della parte femminile nella coppia per quanto riguarda gli aspetti di gestione dell’agenda. Oppure un’estrema volubilità dell’uomo che tende a cambiare partner molto facilmente, alle prime difficoltà caratteriali, ricercando la compagna che accetti senza discutere tutto e sempre. Ma non mi pare sia poi così diverso dalle problematiche di coppia nella vita.
Quando si crea una coppia di tango solo artistica, quindi non nella vita, è interessante notare come le dinamiche relazionali siano talmente pervase del maschile e femminile, in accordo e in conflitto, da somigliare a una specie di relazione di coppia sublimata. Non è come essere colleghi d’ufficio, per intenderci.
Per muoversi in questo ambiente come donna, a volte sola, occorre una certa disponibilità alla negoziazione col maschile e la sua parte oscura. Molta pazienza. A volte lasciar correre o lasciar andare anche se si avrebbe voglia di discutere.
Il mio percorso nel tango è stato molto vario, ho lavorato con diversi compagni, nella maggior parte dei casi solo compagni di lavoro. Ho imparato molto sulle relazioni, molto ho sofferto, e ho anche provato molta rabbia. Ma indicibile è tutto ciò che un’esperienza del genere può offrire. Per questo sento il desiderio, nel mio percorso, di condividere e approfondire il lavoro sull’aspetto relazionale di questa danza. E sulla redenzione dal conflitto del maschile e femminile.
Già la redenzione… L’intensità delle tue parole e della tua esperienza mi ha fatto pensare che sarebbe importante che tu potessi portare la cultura del tango nelle scuole, raccontandola e facendola provare ai ragazzi. Quale migliore educazione sessuale e relazionale potrebbe esserci come il tango, come la danza? Aiutare i corpi e le anime a sentirsi è la migliore forma di educazione che noi adulti potremmo pensare per i nostri figli…
Io metterei la danza, molto più che il teatro (che ancora s’identifica, purtroppo e assurdamente, con la parola o la letteratura teatrale) come materia obbligatoria nelle scuole.
Metterei di fronte i ragazzi e le ragazze, chiedendogli di ascoltare la musica e di abbracciarsi senza timore, se lo sentono. O di cercarsi nello spazio, provando a sentirlo amico dei loro desideri.
Non si può insegnare un desiderio, ma si può suggerire a qualcuno, piccolo o grande che sia, di muoversi ed esplorare. Magari lentamente e senza fretta.
E si può abbassare la luce, anche in pieno giorno, e fare lezione a lume di candele e con la voce sussurrata, come provava a fare l’insegnante di musica ed estetica dell’indimenticabile film Insalata russa di Y. Mamin, prima che l’incanto di quella sua lezione fosse infranto dall’arrivo del bidello.
La porta si apriva, sul più bello, e la luce si riaccendeva senza pietà alcuna, facendo apparire un uomo con delle grandi scatole in mano… contenenti dei computer.
O si può tirare fuori la “poesia” di un ragazzo incitandolo a non far passare l’attimo fuggente, ritraendosi al momento giusto e nel posto giusto.
La redenzione è nell’ascolto, a mio parere, continuo e instancabile. Il solo che può avvicinarci tanto da far sparire anche solo l’idea dell’appartenenza. L’appartenenza, la fiducia sono in noi e oltre di noi. Un tango può indicarci la strada di questa radice e di questa frontiera, in mezzo alla quale stiamo tutti… in attesa. Tra l’essere e il non essere.
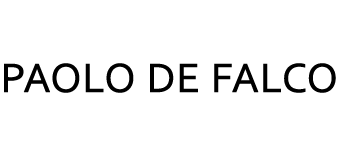









 dei musical tanto di moda, aldilà del commercio dei tutù e delle luci colorate che li illuminano a fine stagione, emesse dai tanti light designer (un tempo si chiamavano tecnici delle luci) che nel bene e nel male si sforzano di portare un po’ di vitalità al cigno morente (magari levassero tutti quegli inutili effetti che offuscano il meraviglioso spettacolo della “morte”), e aldilà dell’energia “coatta” del ballo televisivo, c’è stato un momento in cui anche in Italia la danza stava diventando contemporanea.
dei musical tanto di moda, aldilà del commercio dei tutù e delle luci colorate che li illuminano a fine stagione, emesse dai tanti light designer (un tempo si chiamavano tecnici delle luci) che nel bene e nel male si sforzano di portare un po’ di vitalità al cigno morente (magari levassero tutti quegli inutili effetti che offuscano il meraviglioso spettacolo della “morte”), e aldilà dell’energia “coatta” del ballo televisivo, c’è stato un momento in cui anche in Italia la danza stava diventando contemporanea. Questa artista è Silvana Barbarini che è stata una fondatrice del Gruppo Danza Contemporanea (Genova, 1981), dell’Associazione Vera Stasi (Roma, 1985), dell’ Associazione Tuscania Teatro (Tuscania, 1997), che ha fatto parte del gruppo di studio Musica2000/Danza d’Autore (1994-96), che ha partecipato alla creazione dell’ Associazione Coreografi Autori Indipendenti (1995).
Questa artista è Silvana Barbarini che è stata una fondatrice del Gruppo Danza Contemporanea (Genova, 1981), dell’Associazione Vera Stasi (Roma, 1985), dell’ Associazione Tuscania Teatro (Tuscania, 1997), che ha fatto parte del gruppo di studio Musica2000/Danza d’Autore (1994-96), che ha partecipato alla creazione dell’ Associazione Coreografi Autori Indipendenti (1995). educativi. Ma non c’è più una trasmissione di padre in figlio delle danze. Come non c’è più una trasmissione di padre in figlio dei mestieri.
educativi. Ma non c’è più una trasmissione di padre in figlio delle danze. Come non c’è più una trasmissione di padre in figlio dei mestieri. Già. Credo che la perdita della danza e del corpo sia anche in relazione con la perdita del pensiero. Sembra un paradosso dato che la danza si nutre di depensamento, di abbandono della razionalità, celebra l’energia “corale” che può radunarsi anche in un solo corpo, eppure se non c’è il pensiero, se manca l’atto profondo del pensare, anche la danza si spegne o si riduce a divertimento, a fuga. Ma pensando a questo voglio chiederti se credi che la danza contemporanea, almeno in Italia, abbia poco “pensato”, abbia poco proposto di essere vissuta, letta anche con il pensiero.
Già. Credo che la perdita della danza e del corpo sia anche in relazione con la perdita del pensiero. Sembra un paradosso dato che la danza si nutre di depensamento, di abbandono della razionalità, celebra l’energia “corale” che può radunarsi anche in un solo corpo, eppure se non c’è il pensiero, se manca l’atto profondo del pensare, anche la danza si spegne o si riduce a divertimento, a fuga. Ma pensando a questo voglio chiederti se credi che la danza contemporanea, almeno in Italia, abbia poco “pensato”, abbia poco proposto di essere vissuta, letta anche con il pensiero.